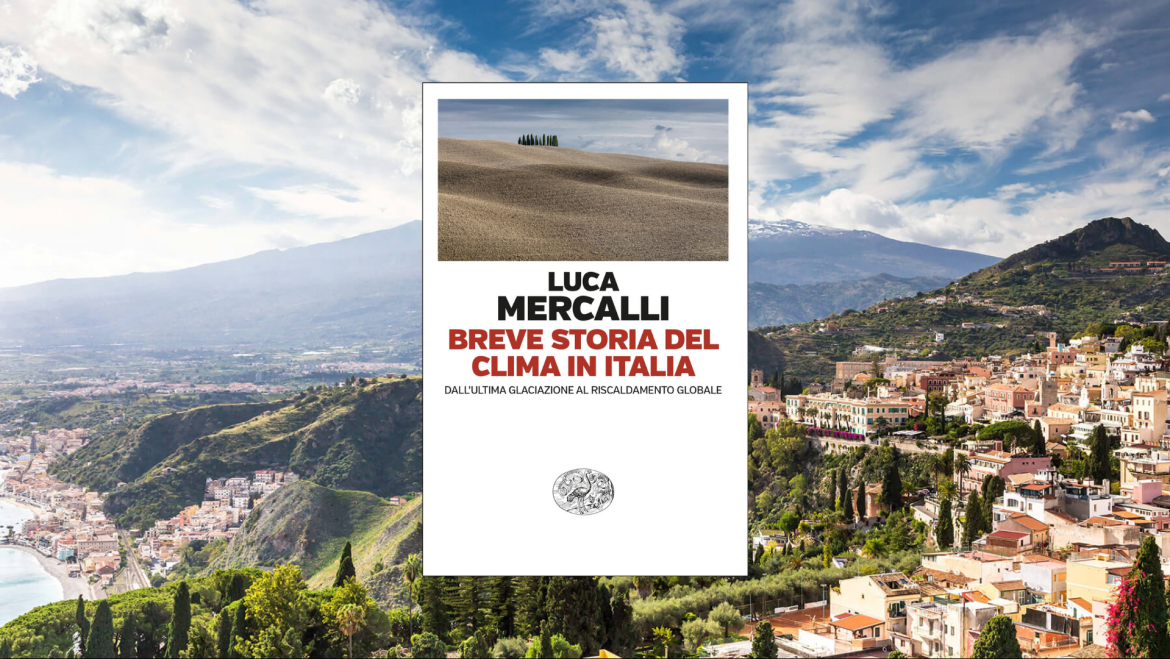Luca Mercalli
BREVE STORIA DEL CLIMA IN ITALIA
Dall’ultima glaciazione al riscaldamento globale
prefaz. di Christian Rohr,
pp. VIII-248, € 18,
Einaudi, Torino 2025
Luca Mercalli è un noto divulgatore scientifico, fondatore della rivista “Nimbus” e autore di vari libri su clima, ambiente e ghiacciai. Collabora con l’Oeschger Centre for Climate Change dell’Università di Berna; il master in geografia alpina e scienze della montagna, conseguito all’Università di Chambéry, spiega il grande interesse per l’ambiente alpino.
L’argomento rientra in un filone multidisciplinare che propone una diversa visione della storia: non più come risultato dell’iniziativa di alcuni personaggi, ma di un condizionamento ambientale. Storici, antropologi, climatologi, geografi sono invitati a interagire e cercare una visione unitaria che colleghi le vicende umane, politiche, economiche e sociali, con le condizioni climatiche e i loro cambiamenti. I fattori climatici pongono sfide e naturalmente l’uomo può reagire in diversi modi. Si tratta di un contesto probabilistico, non deterministico come alcuni avevano pensato alle origini. Questo filone di ricerca si sviluppò soprattutto in Francia con Fernand Braudel ed Emmanuel Le Roy Ladurie, in Inghilterra con Hubert Lamb, e in Svizzera con Christian Pfister. In Italia si sono realizzate molte ricerche e pubblicazioni specialistiche su temi o periodi specifici, ma soltanto due libri a livello divulgativo rispetto ai quali questa nuova opera si presenta con una propria originalità, senza sovrapporsi ai precedenti.
Il titolo specifica “breve” perché in poco meno di 250 pagine parte dalla scala geologica, e seguendo tappe fondamentali arriva ai Romani dando un contesto ambientale alle vicende storiche, per poi passare all’alto medioevo, alla Piccola Età Glaciale (peg), e infine giungere ai tempi moderni del riscaldamento globale, costellato da calamità. Alla brevità s’accompagna la scelta di eventi spettacolari, come gelate, nevicate, esondazioni, tempeste, con tutta la loro drammaticità e il loro impatto sulla società e sul territorio.
Il libro si svolge a volte in chiave autobiografica, a volte presentando brani di letteratura che permettono di riconoscere situazioni climatiche o di eventi estremi accaduti in Italia. Il genere letterario è intermedio a tre tipologie: 1) il classico saggio introduttivo, che riassume le parti salienti di un certo argomento, con la presentazione fatta nel pieno rispetto delle citazioni a cui rimandare il lettore per approfondimenti; 2) il genere narrativo, di facile lettura, con argomenti storici e letterari; 3) il genere didattico-divulgativo, che mescola fatti umani con fenomeni naturali a lungo o breve periodo, per stuzzicare la curiosità del largo pubblico.
L’esperienza basata sui ghiacciai e sull’arco alpino, insieme con l’aderenza alla “scuola svizzera”, porta Mercalli ad alcune semplificazioni che non sempre si adattano al territorio italiano e alla sua complessità. Per esempio “se si eccettua la regione alpina, l’Italia è rappresentativa del clima mediterraneo delle medie latitudini (tra 36 e 46° N) che ha come carattere principale un inverno fresco e piovoso e un’estate lunga, calda e molto asciutta”. Va detto che l’Italia è divisa in otto regioni climatiche, e solo la parte meridionale ha il clima mediterraneo sopra descritto. Escluse le Alpi, l’Italia settentrionale e centrale ha precipitazioni in tutte le stagioni, con la massima piovosità concentrata in primavera (maggio-giugno) e soprattutto autunno (ottobre-novembre), all’arrivo delle perturbazioni atlantiche, rafforzate durante il passaggio sul Mediterraneo occidentale. Questa è la chiave di lettura delle varie alluvioni nel nord e centro che si trovano ampiamente raccontate nel libro e che non si possono giustificare nei termini del clima mediterraneo.
La peg è presentata secondo l’interpretazione storica: “il raffreddamento della peg, che fu il più pronunciato e duraturo di tutto l’Olocene nell’emisfero Nord, valutato in una riduzione della temperatura media annua di 0.6 °C rispetto alla media dell’ultimo millennio, può essere attribuito principalmente all’intensificarsi dell’intensità vulcanica dopo il periodo di quiete attorno all’anno Mille, e secondariamente alla riduzione dell’attività solare durante i grandi minimi di Wolf (1280-1350), Spörer (1420-1550), Maunder (1645-1715) e Dalton (1790-1830)”. In Italia, i più recenti studi sulle osservazioni termometriche giornaliere (disponibili dal 1654 al 1670, e poi dopo il 1715) non mostrano un abbassamento generalizzato delle temperature ma propongono una visione un po’ diversa. Riportano un quadro normale, simile al Novecento, ma funestato da alcuni eventi estremi che caratterizzarono la peg. In particolare si verificarono alcune situazioni meteorologiche avverse (chiamate “blocco”) per cui l’arrivo di aria dal nord causò un freddo molto intenso per due o tre settimane, con effetti drammatici. Nel Settecento si ebbero cinque di tali “grandi inverni” (seguiti da estati del tutto normali); nell’Ottocento nessuno, e successivamente solo nel 1929. Volta per volta, l’afflusso di aria fredda interessò gran parte dell’Europa o alcune aree geografiche diverse, a seconda della circolazione atmosferica. In alcuni casi l’Italia fu protetta dall’arco alpino, per cui non risentì del grande freddo riscontrato in altre parti.
Il libro non è un trattato di climatologia, e non richiede una preparazione di base. Quanti desiderano un’introduzione al clima e agli eventi che hanno accompagnato la storia, troveranno numerosi esempi raccontati con parole semplici. È una raccolta antologica con un po’ di letteratura, con punti di vista storici e fatti spettacolari presentati con garbo. Il testo è senza formule, scorrevole e accattivante.