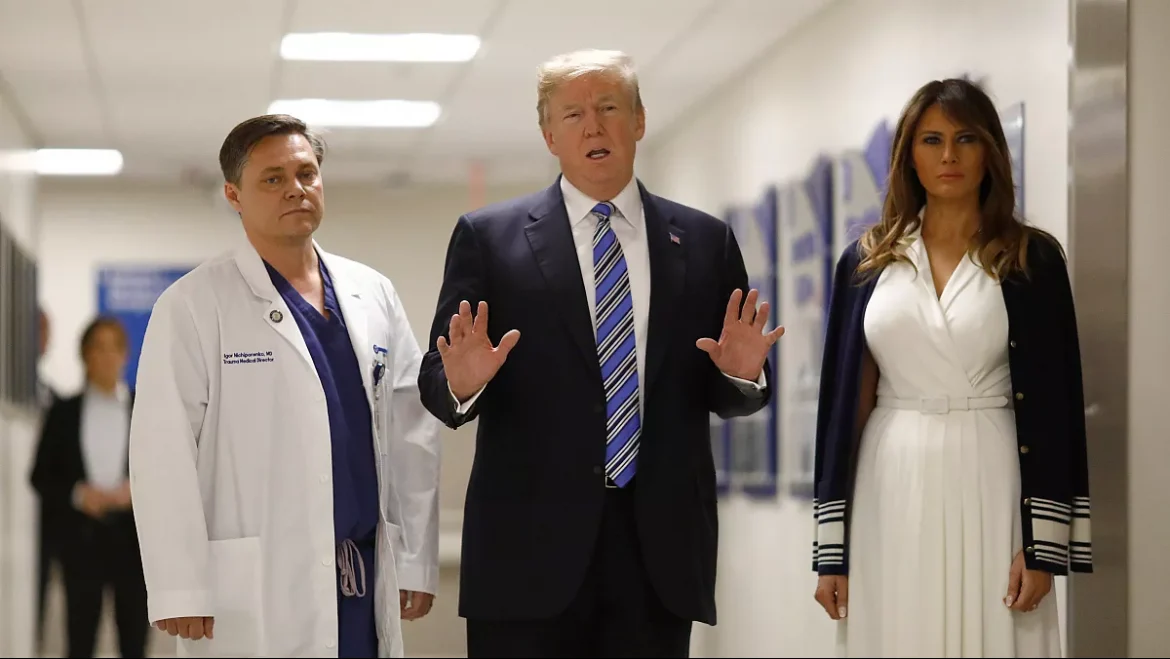Il primo luglio 2025, Brian Sandberg, un esperto di cambiamenti climatici, ha varcato i cancelli dell’Università di Aix-Marseille, accolto dai fotografi e da una piccola folla di curiosi. Si tratta del primo beneficiario del programma Safe Place for Science, lanciato dall’ateneo francese per accogliere quelli che vengono ormai definiti “rifugiati scientifici”, studiosi che lasciano gli Stati Uniti d’America a causa delle politiche sulla ricerca introdotte dall’amministrazione Trump. Secondo la rivista “Nature”, questo fenomeno è destinato a crescere: negli ultimi mesi, le ricerche di posti di lavoro in Europa da parte di scienziati che vivono negli Usa è aumentato del 30 per cento rispetto all’anno scorso e diverse università europee si stanno organizzando per accoglierli. Questa diaspora scientifica è solo l’ennesima conseguenza di una guerra a tutto campo che l’amministrazione Trump sta conducendo, non solo nei confronti delle università americane, ma dell’intero sistema della conoscenza e della ricerca. La prima fase di questo conflitto ha coinvolto alcune agenzie federali, tra cui i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), l’Environmental Protection Agency (Epa), la Food and Drug Administration (Fda), i National Institutes of Health (Nih), e la National Science Foundation (Nsf), che sono fondamentali per l’ecosistema della ricerca, non solo perché presso di loro lavorano centinaia di migliaia di scienziati, ma anche perché finanziano gran parte della ricerca accademica e sono responsabili degli aspetti regolatori in ambito scientifico (ad esempio l’approvazione dei farmaci). Nel giorno del suo insediamento, Trump ha emanato alcuni ordini esecutivi che vietano qualunque riferimento all’identità di genere e aboliscono tutti i programmi di promozione della diversità, equità e inclusione (Diversity, Equity, Inclusion-
La seconda fase ha coinvolto direttamente gli atenei. L’Nih e la Nsf sono i più importanti finanziatori della ricerca accademica in America; da gennaio, però, le università possono beneficiare di tali fondi solo se rispettano gli ordini esecutivi sull’identità di genere e i Dei. Va peraltro sottolineato che l’amministrazione Trump non ha mai stilato un elenco esaustivo dei vocaboli vietati. Ciò ha causato la nascita di numerose liste non ufficiali, che contengono i termini più vari (Pen America, una ong che si occupa di libertà di espressione, ne ha censiti più di 300, tra cui women, climate change e afroamerican), provocando ulteriore confusione e la nascita di fenomeni di autocensura da parte di individui e istituzioni che spesso evitano di proporre progetti di ricerca su temi percepiti come non graditi all’amministrazione. Un’altra linea di attacco contro gli atenei sfrutta invece una legge pensata per impedire la discriminazione all’interno dei programmi finanziati con fondi federali. Usando questo stratagemma, il governo ha improvvisamente revocato fondi per 400 milioni di dollari alla Columbia University, accusandola di non aver impedito atti di antisemitismo durante le proteste universitarie. Decine di altri atenei, tra cui Harvard, sono oggetto di indagini analoghe; quest’ultima ha però deciso di affrontare la questione in sede giudiziaria. Tale decisione è stata presa dopo che l’università ha ricevuto una serie di richieste inaccettabili da parte dell’amministrazione, tra cui un controllo governativo sulle procedure di assunzione del personale e di ammissione degli studenti. Per colpire ulteriormente le finanze degli atenei, a partire da aprile il governo ha annullato visti e permessi di soggiorno di migliaia di studenti internazionali e in diversi casi ha proceduto alla loro deportazione; inoltre, ha reso più rigidi i criteri per l’emissione di nuovi visti per motivi di studio e ricerca. Le decisioni adottate hanno generato un clima di incertezza economica che ha spinto molte università a bloccare le assunzioni e a ridurre i posti disponibili per i dottorati, che quest’anno rischiano di essere ridotti del 30 per cento, riportando i numeri ai livelli di vent’anni fa.
Una terza fase del conflitto è stata inaugurata a fine maggio, con l’emanazione dell’ordine esecutivo denominato Restoring gold standard science. Dietro un linguaggio che, apparentemente, sembra promuovere l’eccellenza nella ricerca scientifica, la direttiva stabilisce in realtà che, affinché i risultati di una ricerca possano essere impiegati a fini regolatori, lo studio debba rispettare standard metodologici molto rigorosi, difficilmente raggiungibili nella ricerca applicata (ad esempio in campo biomedico). Questa strategia, adoperata in passato anche dall’industria del tabacco, di fatto rende estremamente difficile l’implementazione di interventi preventivi in ambito sanitario e ambientale. Inoltre, l’ordine esecutivo conferisce a un incaricato politico il potere di decidere quali risultati debbano essere considerati rilevanti e addirittura di intraprendere azioni disciplinari contro i ricercatori che vengono ritenuti responsabili della divulgazione di dati e conclusioni non in linea con la posizione ufficiale del governo. Quella che sembra profilarsi è una visione grottesca della scienza, nella quale l’amministrazione si arroga il potere di stabilire non solo quali quesiti di ricerca siano legittimi, ma anche quali risposte siano accettabili. D’altra parte, diversi membri del governo non hanno mai fatto mistero della poca considerazione nella quale tengono le istituzioni volte alla generazione e alla diffusione delle conoscenze scientifiche. Robert Kennedy jr, attualmente a capo della sanità americana, ha recentemente ribadito che considera inaffidabili e corrotte tutte le più importanti riviste scientifiche mondiali e sta valutando di vietare ai ricercatori federali di inviare i propri studi a questi giornali. Se non bastasse, il Dipartimento di Giustizia ha contattato negli ultimi mesi decine di riviste mediche, mettendo in discussione le loro politiche editoriali e sollecitando che sulle loro pagine venga concesso spazio anche a sostenitori di “punti di vista divergenti”, secondo un principio di falsa equidistanza, più frequentemente usato in ambito televisivo che non scientifico. Il mondo dell’editoria medico-scientifica ha sicuramente molti problemi di credibilità (come viene ben raccontato nel libro di De Fiore, Sul pubblicare in medicina, Il Pensiero Scientifico, 2024, su cui cfr. “L’Indice” 2024, n. 7-8), ma sembra difficile pensare che i correttivi proposti dal governo americano possano ricostituire una presunta neutralità perduta all’interno del discorso scientifico. D’altra parte, la recente pubblicazione del rapporto governativo Make Our Children Healthy Again, pieno di inesattezze e citazioni bibliografiche inesistenti, o l’insistenza di Kennedy nel voler condurre nuovi studi sull’associazione tra vaccini e autismo, nonostante questa sia stata da tempo esclusa dalla comunità scientifica, non fanno che destare ulteriori dubbi sulla concezione di scienza che caratterizza questa amministrazione.
Alla fine della Seconda guerra mondiale, la pubblicazione del rapporto Science, the Endless Frontier: a Report to the President, 1945 (il Manifesto per la rinascita di una nazione di Vannevar Bush, Bollati Boringhieri, 2013), commissionato dal presidente Frankie Delano Roosevelt, ha inaugurato una nuova politica della scienza, fondata su generosi finanziamenti pubblici e sulla piena autonomia degli scienziati di perseguire qualunque filone ritenessero promettente. Per quasi un secolo, questo modello ha reso gli Usa il luogo ideale dove fare ricerca e ha profondamente influenzato i valori e le pratiche con cui l’attività scientifica viene condotta e percepita in tutto il mondo. Sotto la nuova amministrazione Trump, se ancora esiste una frontiera della scienza, questa non è più in America.